|
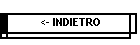
| |
La fine del manicomio:
un'occasione mancata?
Tommaso Losavio
letto al convegno "Contenere, curare la
follia", organizzato da AIPsi e ASL RM E,
S. Maria della Piet� di Roma il 27.11.04.
La fine del manicomio: un�occasione
mancata?
La fine del manicomio avrebbe dovuto
rappresentare un�occasione irrepetibile per un�innovazione non solo sul
piano dell�ingegneria e dell�architettura istituzionale (i nuovi servizi a
centralit� comunitaria) ma anche e soprattutto come rottura definitiva con quei
modelli culturali ed assistenziali che per tanti anni avevano sostenuto ed
alimentato quella istituzione finalizzata alla cura della follia, riconosciuta
come malattia.
L�aspetto centrale della pratica di un
servizio di salute mentale di comunit� doveva essere:
- "il prendersi cura" nel suo svilupparsi nell�incontro
tra il tempo del paziente e il tempo dei suoi curanti,
- l�attenzione a cogliere non solo la malattia e i suoi
sintomi come fenomeno, ma i diversi momenti e le diverse forme dell�esistenza-sofferenza
del paziente
- i molteplici rapporti che legano il paziente alla sua
storia ed al suo contesto sociale.
Le condizioni operative prima che
organizzative dovevano ricercarsi:
- nel tempo della cura (il tempo della domanda a volte
tumultuoso, altre volte lentissimo e sorprendente, contrapposto al tempo del
setting della risposta il pi� delle volte rigido e burocratico);
- nella dimensione dell�asimmetria del rapporto (la
consapevolezza del dislivello di potere che separa l�operatore dal
paziente, specie dal paziente pi� grave;
- nella consapevolezza dell�arbitrariet� dell�uso di
conoscenze, parziali e relative, spesso assunte come totali ed assolute, e
di competenze provvisorie;
- nella tendenza a stabilire la relazione con il paziente
sulla reciprocit� e sull�affermazione della reciproca soggettivit� come
alternativa all�oggettivizzazione, pi� abituale, in qualsiasi rapporto
tra curante e curato.
Il prendersi cura doveva essere anche
alternativo a nuove forme di istituzionalizzazione, un metodo di lavoro che, in
assenza di istituzioni totali, riuscisse a:
- confrontarsi anche con problemi apparentemente insolubili;
- realizzare un rapporto di cura collocato nella prospettiva,
costantemente e tenacemente perseguita, "dell�esclusione dell�esclusione"
- attribuire, o a restituire, con modalit� concrete alla
sofferenza del curato (ed al modo con il quale viene espressa) il diritto di
appartenere all�universo del senso.
Nella pratica della deistituzionalizzazione
per il superamento dell�ospedale psichiatrico abbiamo imparato a ripercorrere
a ritroso la trama dei pregiudizi di cui era intessuta la carriera dell�internato
e a non attribuire tutto il comportamento dell�internato, i suoi atti, le sue
parole, i suoi desideri alla malattia mentale. Era la sospensione di giudizio
usata da F.Basaglia, la messa tra parentesi della malattia, l�epoch�
secondo Husserl.
Tutto ci� pu� realizzarsi, forse, nella
ricerca tendenziale, e mai completamente realizzabile, di ci� che emerge in
quanto tale, non in quanto essenza ipotizzata ed arbitrariamente interpretata,
n� in quanto categoria predefinita.
Prendersi cura, quindi, di quella esistenza e
di quella sofferenza cos� come si presentano e si dispongono nel loro essere
nel mondo e nel mondo di quella relazione.
Tutto questo per qualcuno ha voluto
significare, e significa ancor oggi, "la negazione" della malattia.
Ed infatti, per esempio, per giustificare il
modello neo-istituzionale ripresentato non solo dalle proposte di legge di
contro-riforma, ma anche dalle pratiche di molti servizi, l�irrecuperabilit�
del malato di mente viene ancora utilizzata per riproporre la riabilitazione
come intrattenimento, nel senso pi� letterale del termine ma anche come
tentativo di normalizzazione e di controllo sociale, indipendentemente dalle
tecniche usate e in rapporto pi� stretto con lo stile di lavoro degli operatori
e con la "politica" di salute mentale adottata dal servizio.
Certamente si pu� fare riabilitazione in modi
molto diversi tra loro: ad una discreta riabilitazione sociale intesa come
recupero e/o apprendimento di competenze sociali non necessariamente corrisponde
l�acquisizione di una reale e concreta capacit� contrattuale intesa come
rapporto d�interdipendenza paritaria e come rispetto e valorizzazione della
diversit� rappresentata dal paziente. Spesso, al contrario, l�intervento
riabilitativo, integrato quanto si voglia, valutato e supportato dalle tecniche
pi� in voga del momento, ha come finalit� generalmente non confessata e spesso
neppure consapevole, di indurre e mantenere dipendenze che pi� facilmente
possono garantire forme di controllo sociale anche per lunghissimo tempo.
L�obbiettivo, condiviso dal paziente, dagli
operatori ma anche dai famigliari e dal contesto sociale di appartenenza, di
conquistare un pieno diritto di cittadinanza, che possa esercitarsi
concretamente ed esprimersi nelle forme originali proprie del soggetto, dovrebbe
essere rappresentato dal reciproco riconoscimento e del reciproco rispetto
piuttosto che dall�adesione o, peggio, dalla costrizione, a modelli di
normalit� (o di normalizzazione) passivamente accettata.
Un noto rapporto di qualche anno fa della
World Bank nell�affrontare i temi del disagio sociale e delle sue
interdipendenze sottolineava che lo sviluppo di una comunit� che si realizza
attraversa processi che disuniscono/indeboliscono il capitale sociale (inteso
come coesione sociale, valori eticamente condivisi, grado di raggiungimento dei
diritti di cittadinanza, comunicazione, scambio di esperienze) produce
vulnerabilit� verso povert� di una parte della comunit�, comportamenti
patogeni, alcune malattie mentali e l�aggravamento di altre. Povert�,
comportamenti a rischio e malattie mentali hanno fattori di rischio strettamente
interdipendenti, tanto che ciascuna di queste condizioni pu� provocare l�altra:
ci� determina l�assoluta necessit� di un approccio di salute pubblica ai
problemi psichiatrici che consenta di collegare la psicopatologia e la
sofferenza del "caso" con gli elementi socio-ambientali e di contesto
che ne definiscono i fattori di rischio (individuale e collettivo), quelli di
protezione e le variabili che incideranno sulla possibilit� di effettuare un
idoneo trattamento e sulla sua efficacia. Per occuparsi della salute mentale
bisogna considerare una serie di fattori collegati a livello delle singole
comunit� che, ad un primo sguardo, potrebbero non sembrare problemi
psichiatrici. E� possibile cos� identificare forze e risorse locali che
possono contribuire a creare programmi territoriali che tengano conto delle
tradizioni locali e dei valori culturali.

Il
modello razionale
Il tipo di razionalit�, su cui sembra sempre
pi� fondarsi la nostra cultura, di poter prevedere e controllare tutto,
ovviamente deve fare i conti in modo diverso con il dramma delle domande poste
dalla sofferenza psichica e in particolare a quelle a cui non si riesce a
trovare ancora risposta.
Non poteva bastare, quindi, umanizzare
semplicemente l�assistenza: era necessario anche mettere in discussione la
cultura medica tradizionale ed il suo modello scientifico fondato
prevalentemente sull�oggettivazione. Il contratto terapeutico, ad esempio,
asimmetrico per sua natura, pu� cos� tendere pi� alla riduzione dello spazio
fisico, psicologico, relazionale e sociale del paziente psichiatrico e come
corollario di garanzia di controllo, invece che come ampliamento di spazio
vitale tendente alla graduale conquista di una interdipendenza paritaria, di un�autonomia
e di una responsabilit� perdute o mai raggiunte.
I servizi che operano con il modello del
prendersi cura sono obbligati a confrontarsi quotidianamente con la complessit�
dei problemi e gli utenti pi� che mai visibili restano in carico. Il piano di
lavoro, che agisce su tutti gli elementi in gioco che favoriscono consapevolezza
e responsabilit�, prevede l�attivazione di (sempre) nuove prospettive e
percorsi nella ricerca di risposte a problemi che risultano molto pi� complessi
e articolati di quanto la semplice riduzione a "malattia" possa
consentire di comprendere e di risolvere. Il piano deve necessariamente attivare
nuove prospettive nei confronti di un "rischio" che non pu� ricadere
soltanto su chi � portatore della sofferenza, per farlo sparire, ma che rientra
nel mondo di tutte le relazioni possibili. Deve ancora mettere in discussione i
processi di delega, di appalto e di occultamento che vengono demandati al
tecnico (gli operatori dei servizi) tradizionalmente riconosciuto pi� come
tutore dell�ordine e della sicurezza, che come competente tutore e promotore
di salute.
Che cosa capiter� a quella persona che
soffre, a quel contesto familiare disperato se noi (il singolo operatore, il
gruppo di lavoro, il servizio) non ci prenderemo in carico quella situazione?
Quanto pi� oscura e difficile risulta la risposta, tanto pi� (afferma Jonas)
nitidamente delineata dovrebbe essere la nostra responsabilit� nel prendercene
cura. Responsabilit� non solo di trattamento, ma necessit� di prendersi cura,
di attenzione, di preoccupazione, di rispetto. Jonas aggiunge che quanto pi�
problematico ed inusuale � nel manifestarsi ci� che temiamo o ci� che ci
tiene in apprensione, tanto maggiore dovrebbe essere la chiarezza dell�immaginazione
e la sensibilit� emotiva da mobilitare ed indirizzare nei modi opportuni per
cercare le soluzioni possibili ma anche le pi� adeguate per risolvere quella
situazione.
Nel momento in cui si opera curando l�altro
che soffre, si dovrebbe essere consapevoli che si entra in una dimensione che
non � mai soltanto tecnologica, ma anche e soprattutto etica: la dimensione
etica di questo specifico atto di cura e del progetto pi� complessivo di presa
in carico. Il solo sapere non basta, perch� la dimensione etica del prendersi
cura non invia soltanto all�intervento ideale e perfetto, quanto piuttosto al
ripiegamento dell�atto su se stesso alla ricerca non tanto del come quanto del
perch�.
"Le nostre societ�, afferma Benasayag,
finiscono per credere, nel senso profondamente antropologico del termine, che il
reale debba disciplinarsi e disporsi secondo griglie, modelli e concetti".
La relazione con il mondo e con gli altri diviene cos� una relazione con i
modelli e, una volta fissate etichette e modelli prendono il posto del mondo. E�
il passaggio, secondo l�Autore argentino, dall�epoca dell�etica a
quella dell�etichetta.
Non basta soltanto decidere, si deve decidere
per il meglio, un meglio che nella psichiatria � ancora oggi oscuro, dubbioso e
confuso.
Un meglio che pi� spesso di quanto se ne
abbia consapevolezza � condizionato da pregiudizi, da rischi di usi distorti o,
pi� semplicemente, da abusi.
Cura quindi non come semplice cura della
malattia n� tanto meno riduzione della libert�, ma piuttosto come tutela e
protezione della persona sofferente, che a causa della sua sofferenza corre
rischi che mettono in gioco la sua capacit� di libert� e di autodeterminazione
in alcuni momenti e in alcune circostanze della storia della sua sofferenza e
della sua vita.
Non mancheranno i momenti difficili nei quali
la relazione faticosamente costruita viene messa in discussione e subisce
attacchi anche furibondi da una parte e dall�altra che a volte potranno anche
essere letti come paradossale ma prepotente richiesta di maggiore protezione e
provocatoria sfida e messa alla prova delle capacit� di tenuta.
Cura come possibilit� di relazione, che a
volte pu� divenire anche drammatica, con l�assunzione di una funzione di
protezione che in alcuni momenti pu� farsi anche molto forte ma che deve in
ogni momento seguire la prospettiva di attribuzione e/o restituzione di
riconoscimento di soggettivit� .
E quando la cura pu� divenire anche un
obbligo (sia a curare che a curarsi) � necessario cercare il suo superamento in
una reciprocit� che sfocia in un rapporto di fiducia che scioglie, nel fluire
delle relazione tra persone, la rigidit� delle contrapposizioni tra diritti e
doveri. I diritti e doveri del curante e del curato possono assumere cos� una
concretezza lontana da processi di distanziamento, di contrapposizione e talora
di sopraffazione per divenire una leva per rafforzare legami che, a partire
dalla relazione, si trasformino in possibili risorse di riproduzione sociale.
Perch� la volont� e la libert� di ognuno di
noi non sono valori astratti, decontestualizzati, sempre uguali dovunque e in
ogni momento allo stesso modo. Al contrario sono relativi alle reali condizioni
di vita, esistono nella misura in cui siamo in grado di perseguirli con
serenit�, agirli in rapporto a contesti che permettano livelli adeguati di
autodeterminazione e contrattualit�, di sviluppo di autonomia affettiva,
emotiva decisionale. Volont� e libert� necessitano di scenari che permettano
loro un�adeguata rappresentazione: quando il rapporto tra la persona e il suo
contesto si incastra , per molteplici motivi, in una condizione di sofferenza
che pu� manifestarsi, per difendersi dall�angoscia con la malattia, la
resistenza sino al rifiuto della cura si collocano nella dimensione della
coazione piuttosto che della libert�. L�assunzione di una decisione per il
paziente in questi momenti � anche assunzione non facile di responsabilit� per
tentare di sbloccare una situazione di irrigidimento nella quale chi soffre non
riesce neppure a trovare strumenti dialettici adeguati.
La funzione di tutela in un rapporto rotto,
lacerato e drammaticamente sofferto, prima con se stessi che con gli altri,
costituisce uno dei momenti di maggiore difficolt� e tensione dove spesso
entrano in gioco in modo esplicito o implicito, consapevole o inconsapevole,
vissuti ed agiti di sopraffazione e/o di abbandono e di rifiuto, dove invece �
necessario, anche se difficile, trovare i modi per sciogliere le tensioni, per
sdrammatizzare la situazione, per restituire senso agli accadimenti, per
valorizzare le soggettivit� che rischiavano di frantumarsi, per rimodulare e
riorganizzare, in fine, le relazioni .
Se � certamente vero che la nuova dimensione
operativa del servizio di salute mentale di comunit� permette scenari
inimmaginabili nell�istituzione manicomiale, � altrettanto vero per� che i
nuovi servizi non sono immuni da pratiche neo-istituzionali (reparti
psichiatrici in cui si abusa di farmaci e contenzioni, invii in cliniche private
dove il paziente viene dimenticato, residenze come depositi, attivit�
ambulatoriale specialistica per la somministrazione di farmaci o di psicoterapie
pi� che centri di salute mentale) che tendono a sequestrare il problema o ad
abbandonarlo. Che sono, come storicamente dimostrato, facce della stessa
medaglia.
I servizi (e l�operativit�) centrati sul
trattamento, che vedono i problemi esclusivamente dal punto di vista della
soluzione, sono servizi in cui gli utenti spariscono: il problema viene
riconosciuto solo se solubile, altrimenti viene negato con un�operazione che
mistifica la sofferenza classificandola come irrecuperabile, creando specifici
spazi per contenerla e custodirla, costruendo la disciplina che giustifica e
amministra la negazione del problema insieme alla negazione di chi ne � il
portatore.
La trasformazione di risorse (specifiche del
servizio e aspecifiche del contesto) in capacit� proprie dell�utente
costituiscono una fase di transizione del processo di cura che costringono a
ricercare anche nel contesto e nella sua rete le offerte capaci di realizzare
questa trasformazione in modo concreto, nella quotidianit�, secondo un progetto
che non pu� che essere di lunga durata. Ricerca di un reticolo che non va
inteso soltanto come servizi sociali e sanitari o come luoghi fisici, ma
soprattutto come (dice Petrella) la rappresentazione delle relazioni emotive e
della trama narrativa che le contiene, come luoghi fisici ma anche luoghi della
mente, come storia del paziente e storia del suo contesto, come dimensione
intrapsichica ma anche come dimensione relazionale e sociale.

Le trasformazioni
del Welfare
Se concordiamo che il prendersi cura sarebbe
dovuto essere l�aspetto centrale della pratica del servizio di salute mentale
di comunit� � necessario anche concordare su quali siano le condizioni
organizzative minime e preliminari perch� essa si possa realizzare :
- la referenzialit� verso un ambito territoriale definito e
delimitato la disponibilit� di risorse adeguate (economiche e di personale)
rispetto alle richieste di quel territorio;
- la non selezione della domanda come regola a cui attenersi
ma anche come obbiettivo da perseguire giorno dopo giorno; ma anche una
regolamentazione delle risposte in funzione della gravit� dei bisogni e
delle risorse disponibili ed attivabili;
- la continuit� terapeutica come capacit� di dare priorit�
alla relazione con il paziente evitando separazioni e scissioni tra le
singole attivit� e servizi;
- la capacit� di organizzare il servizio in modo tale da
essere in grado di accogliere in modo continuo e stabile le domande e di
dare le risposte ugualmente in modo continuo;
- la capacit� di essere un attivatore della rete sociale e
un moltiplicatore delle risorse di cui essa dispone.
E� il modello di Dipartimento di Salute
Mentale nato dalla legge di riforma ed inserito in una nuova organizzazione
sanitaria e sociale che lo stato si era dato come Welfare assistenziale
chiamato da qualcuno anche Welfare della sicurezza, conquista di una
lunga stagione di esperienze critiche di rinnovamento, di grandi rivendicazioni
di diritti, di nuove generazioni di professionisti.
Questa fase oggi sembra in via di definitivo
superamento: si sta tentando di fare il grande balzo verso il Welfare dei
servizi con la trasformazione aziendale della sanit� pubblica che qualcuno ha
anche chiamato Welfare dell�utilit� .
Welfare dei servizi
che si volevano equi, efficienti e generalisti, che per problemi economici ed
organizzativi ha trasformato le USL in gigantesche ASL nelle quali l�operativit�
viene oppressa da processi di gerarchizzazione, di registrazioni, di
valutazioni, di contrattazioni.
Questo tipo di Welfare si sta
rapidamente trasformando in un Welfare dei consumatori, con organismi
erogatori di prestazioni (tariffate, numerate, quantificate) acquisibili ovunque
sul mercato pubblico o privato. Tutto ci� attiene al pi� moderno scenario del
mercato ove la capacit� contrattuale � garantita da una transazione economica
precisa (anche se virtuale) e i diritti si concretizzano nel valore economico
della transazione intesa come PRESTAZIONE sia come offerta (remunerata) sia come
domanda (indirizzata a prestazioni tariffate).
Le ragioni seduttive di questo modello sono
evidenti e coerenti con tanti altri accadimenti della nostra attualit�.
Ma, al di l� delle probabili facili vittorie
che questo modello ha le potenzialit� di conquistare, � indispensabile
chiedersi se esso � in grado di garantire nei fatti la promozione della salute
e se non tradisca nella sostanza le pratiche di innovazione e di trasformazione
di cui pi� sopra abbiamo parlato.
Non ci convince per diversi motivi:
- prima di tutto perch� al mercato si compra un prodotto, ma
la nostra salute � un progetto che nessuno, in nessun caso, pu� ridurre a
un prodotto;
- la prestazione spendibile ovunque obbliga il mercato dell�offerta
ad attrazioni sospette, ad attese di produttivit�, a prodotti rigidi e
preformati, ad investimenti che possono divenire monopolio esclusivo del
privato, alla induzione di domanda laddove pi� remunerativa � la risposta,
al condizionamento di bisogni nella direzione in cui la produzione vuole (ha
interesse) a sviluppare il proprio mercato;
- la medicalizzazione del bisogno tende ad enfatizzare la
spesa sanitaria sottovalutando o trascurando la rete sociale e le sue
risorse. Si arriver� obbligatoriamente alla situazione nella quale si
dovr� decidere qual � il bisogno al quale si devono risposte, quale tipo
di risposta ed in base a quali criteri. Chi, come, perch� e quando si
prenderanno queste decisioni? Nel frattempo si corre il rischio che i
servizi a dimensione pubblica saranno disfatti: questi pi� o meno
efficienti che siano per loro natura sono e saranno comunque orientati
diversamente, verso un�etica pubblica e una solidariet� che anche se mal
praticate, comunque li fondano e ne giustificano l�esistenza .
- il mercato della sanit� non garantisce l�accessibilit�
alle risorse, non tutela l�equit� della loro utilizzazione, non
garantisce la qualit� (nel senso dell�efficacia pratica) delle
prestazioni.
Mi sembra evidente che, se lo scenario futuro
dell�organizzazione sanitaria avr� queste caratteristiche, tutto quello che
molti operatori hanno tentato di fare per chiudere i manicomi prima, e nei nuovi
servizi dopo, le sue peculiarit�, l�impegno per una nuova cultura e una nuova
pratica, la messa in crisi di certezze e la continua ricerca di risposte
autentiche e mai rigide, i tentativi di restituzione al "sociale"
possono far parte, a buon diritto, del mondo dell�utopia.
A questo mondo non appartiene certamente l�esperienza
drammatica della psicosi.
Ma al mercato questo interessa poco: �
sufficiente trovare, di nuovo, luoghi dove controllarla ed occultarla .
Di luoghi come questi, e il S. Maria della
Piet� � qui a ricordarcelo, molti di noi ne conservano una grande, dolorosa
esperienza.
Nessuno oggi ha l�arroganza (o il coraggio?)
di affermarne la necessit� ma, a volte, mi viene da chiedermi (e da chiedervi):
ma perch� li abbiamo appena chiusi?!

|