|
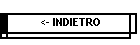
| |
In questo
mondo libero
i luoghi dell�altro
di Ken Loach,
2007
�non sappiamo mai chi stiamo per incontrare,
anche se si tratta di una persona di cui
conosciamo da tempo il nome e l�aspetto�
(R. Kapuściński, 2006).
Il film
Angie ha 33 anni; �
una donna energica e piena di grinta che lavora presso un�agenzia di
collocamento lavorativo per migranti. Quando viene licenziata Angie decide di
mettersi in proprio e di aprire, assieme all�amica Rose, la sua propria agenzia
di reclutamento con un doppio fine: aiutare le persone che ne hanno bisogno e
guadagnare finalmente un po� di soldi per mantenere il figlio, con cui sta
assieme sempre meno. Si scontrer� con il potere mafioso della concorrenza e con
una organizzazione clandestina che difende i diritti dei migranti. Comunque,
cercher� sempre di fare il proprio interesse coinvolgendosi alcune volte nelle
vite tristi degli immigrati e trovando fra loro l�affetto disinteressato di
Karol.
La visione
Ludmilla sorride leggera e timida, e
consegna i soldi ad Angie� di piccolo taglio� di quelli veramente risparmiati
con fatica� contati mille volte per essere sicuri che sono proprio giusti e che
ci sono veramente e che saranno quei soldi a darti una vita diversa. �Dice che
lascia qui due bambine� ha fatto la parrucchiera��. Il film sembra finire, cos�
com�era iniziato: gli schiavi e i mercanti; i sogni, i loro autori e i loro
padroni. Il sorriso timido di Ludmilla ci dice che sar� tradito e, ancora una
volta trover� qualcuno che sopravviver� proprio spegnendo quel sorriso. E� una
strana forma di speranza� quella di essere ciechi a ci� che � evidente e
inevitabile. Ma, gi� nel film, sappiamo che, alcune volte, � la sola forma di
vita, quella di una specie di miraggio. Forse il regista vuole dirsi che le cose
degli uomini, quando toccano la sopravvivenza, non cambiano mai: prevale
l�istintualit� pi� primitiva; l�interesse, la commozione per la vita dell�altro,
sono un lusso che ci si pu� permettere solo dopo che la tua sopravvivenza e i
tuoi oggetti pi� intimi sono garantiti. Io, per�, mi trovo a pensare che
nonostante la parabola sembri chiudersi esattamente laddove era iniziata, di
mezzo c�� un intero film e le persone, se hanno attraversato una storia, non
possono pi� essere quelle di prima.
Agli psicoanalisti questo succede di vederlo
spesso� anche di sentirlo su se stessi. �Questo gliel�ho gi� raccontato,
dottore, si ricorda?� L�analista non ricordava nulla� ora, solo una sensazione
di disagio per non essere laddove la sua paziente lo aspettava. Ma era il suo
mestiere, quello di muoversi continuamente per raggiungere il posto dove i suoi
pazienti lo convocavano e, alla sua paziente lo disse, autenticamente �
che non ricordava e che forse era proprio questo il dolore della sua paziente:
sentire di essere sempre in un altro luogo, sbagliato. Forse questa volta il
disagio dell�analista � una certa sensazione di tradimento � le restituiva di
fatto il diritto di sentire che se una bambina si sente in un luogo sbagliato
deve almeno sentire lo sforzo dell�altro a volerla raggiungere. Nel film
sappiamo anche (ma forse lo sappiamo solo quando si accendono le luci in sala e
ci avviamo all�uscita pensosi e frastornati), che quel sorriso impacciato e
fragile di Ludmilla � quello che salver� tutti, noi e loro, chi spera e chi
sopravvive. Esco piano dalla sala e penso che non ci sono altre vie. Essere
invasi, lentamente e per forza, da una strana forma di speranza che si fa strada
con violenza necessaria: �La grande Muraglia non difendeva dai barbari, li
inventava. Ci serve quel muro, ma non per tenere lontano quello che ci fa
paura: per dargli un nome� Al limite possiamo perdere, ma non perderci��
(Baricco, La Repubblica, 21.10.06). Ognuno faccia la sua parte, ci dice
il film, noi non ci camuffiamo da salvatori perch�, in fondo, nessuno pu�
esserlo, perch�, come per Angie, i figli non sono tutti uguali e quelli tuoi non
sono uguali alle due figlie dell�iraniano �tanto ce ne sono altri� che importa
che quelli non vedranno pi� il loro padre� ce ne sono altri�� Ho avuto paura che
in questi processi, ci sia qualcosa di inevitabile e necessario� che per
cambiare veramente devi essere proprio l�, esattamente dove � l�altro. Lo sforzo
(e la scommessa�) delle analisi � questa: tu sei e rimani l�analista, quello
sdraiato sul lettino �, e rimane, il paziente. Le trasformazioni non accadono
perch� i due si capiscono (questo � piuttosto dell�ordine della suggestione,
inevitabile in ogni relazione, quindi anche analitica�), ma accadono perch�
ciascuno dei due, ad un certo punto � e continuamente � sente che � conveniente
per la propria vita farsi prendere dalle ragioni dell�altro, rimanendo analista
e rimanendo paziente. Gli analisti sanno che � l�asimmetria che muove il
processo e che l�asimmetria porta con se i conflitti e il potere degli uni e
degli altri. Si pu� negare o sedare i conflitti, ma un paziente ed un analista
si incontrano perch� un accordo implicito suggerisce che l�asimmetria � il luogo
in cui due diversit� possono dialogare: �Noi arabi non scriviamo al contrario�
scriviamo da destra a sinistra� Per noi, voi scrivete al contrario� (R.
Andersson, You the living, 2007). Continuo a pensare: �� conveniente per
la propria vita!��.
Oggi al servizio � venuto a cercarmi Mario,
che da sei anni ha perso la moglie e si � messo a vivere nelle case abbandonate
di Calcata. Da qualche tempo l�hanno mandato via e vive sulle rive del lago di
Bracciano, ma � venuto a dirmi che l�hanno mandato via anche da l�. Ha l�aria
aristocratica, tipica, quella dei barboni: una distanza che senti come difesa da
una zona preziosa ed incontaminata del S�. In lui quest�area � ancora pi�
evidente: la barba e i capelli sempre ben curati, la voce calda e l�incredibile
colore bianco panna della camicia e dei pantaloni, di lino, sempre puliti�! Gli
ho parlato sul piano concreto: gli ho detto che non so come aiutarlo� che se
l�hanno mandato via dalla capanna in riva al lago io non so come aiutarlo se lui
continua a rifiutare la casa all�ostello� almeno finch� non troviamo una
sistemazione migliore per lui e la figlia. So bene che il mio mestiere non � di
dare quelle risposte concrete che i pazienti ricevono o possono trovare in mille
altri posti e da mille altre persone, ma non sono riuscito ad evitarlo.
�Dottore, non posso accettare di stare con gente, magari barboni, che nemmeno
conosco� La societ� deve ridarmi la casa che ho perso� ho la mia dignit�!�. Io
so bene di cosa parla e che la casa non � il vero soggetto del nostro discorso.
Anche lui sa che io l�ho capito e forse per questo mi cerca; forse per questo mi
passa la sua disperazione e mi fa sentire impotente. Lui non accetta la casa che
vogliamo dargli, perch� vuole la moglie che ha perso sei anni fa e che per lui
deve rimanere esattamente quella di sei anni fa! Sto al gioco letterale e gli
dico che sono d�accordo� che nessuno pu� offenderlo� che � vero� bisogna
rispettare la sua dignit�. Forse potremmo cercare di trovare una stanza in una
pensione: una stanza tutta per lui� lui che potr� avere le sue chiavi� e ci pu�
andare con la figlia, se vuole! �Ma lei mi garantisce che sar� una stanza in cui
si possano almeno ospitare degli amici� invitare qualcuno a cena?�. Mi sta
chiedendo se posso garantirgli che sua moglie � sempre l� dove lui l�ha
conosciuta e dove ancora lo ama. Gli dico che una stanza sua potr� usarla come
vuole. Mario inizia a sospettare la perdita e mi dice. �Ma mia figlia ha le sue
esigenze� � grande� forse non vorr� stare con me!� Per la prima volta gli ho
visto gli occhi lucidi. Se n�� accorta anche Teresa che era con me mentre
parlavamo insieme. Anche Teresa ha visto (ha sentito) e non ha sottolineato.
Entrambi ci siamo meravigliati perch� non avremmo ancora immaginato le lacrime e
gli occhi lucidi da quell�uomo distinto e barbone, che l�amore per la sua donna
impone sia dignitoso e che vesta di lino bianco� stranamente mai sporco pur
vivendo sulle rive del lago. Dev�essere successo qualcosa� forse gli occhi
lucidi e, per la prima volta, mi sono scoperto a fargli una domanda in cui non
dovevo difendermi proponendogli solo soluzioni concrete che ristabilissero la
distanza, ma mi avvicinavo a lui guidato da una sottile curiosit� verso la sua
zona aristocratica: �come fa per il bucato, Mario?� �Li lavo ogni giorno e li
stendo ad una cordicella appesa fra due alberi�!�
Karol appartiene alla folla dei migranti; �
giovane e bello, anche lui ha una certa aristocrazia nei modi. A lui Angie
chiede qualcosa che non ha e che non ha prezzo mentre lui cerca di imparare il
suo linguaggio: �tenero� � cos� che si dice?�. Quando Angie incontra Karol,
scopre di essere bisognosa a sua volta. Lascer� il suo datore di lavoro, quello
che pu� toccarle il culo se vuole, ma immediatamente dopo, Karol - di cui ha
conosciuto le carezze e l�amore - ridiventa la folla di migranti che ti
permetteranno di fare soldi. Karol come tutti gli oggetti � duplice: un bisogno
pu� essere curato dalla tenerezza, o evitato attraverso la concretezza. E� la
stessa cosa che succede quando Angie conosce come vive un iraniano irregolare e
la sua famiglia �Se ti coinvolgi troppo sei fregata� dice Rose a Angie: �Se
fossi loro mi farebbe piacere aver trovato qualcuno come me� per questo lo
faccio!. E poi subito dopo Angie � pronta a tradire. Forse non � un tradimento..
il film ci dice che � una cosa normale! Un semplice cambio di modalit� di
occuparsi di S�: la tenerezza che immediatamente si ribalta nel cinismo quando
ti fai commuovere dagli occhi delle due bambine iraniane e quando li stai
facendo arrestare.
Il film parla di autenticit�, di quello che
sei nonostante quello che vuoi essere. Non puoi decidere chi essere se non ti
incontri con un altro; � solo lo sguardo dell�altro che ti dice chi sei: �gli
altri sono lo specchio nel quale ci vediamo riflessi� (Kapuściński, 2006, 14).
Si tratta di riconoscere, come nei sogni e nell�inconscio, che le tue sensazioni
ti precedono e sono i tuoi vincoli con la tua terra, la cultura, la giornata che
vivi. Per questo Angie (ma anche Rose e tutti gli altri, �) deve vivere, ma
deve anche sopravvivere. Il film � duro e diretto: �Mi vergogno di quello che
hai fatto Angie� noi viviamo alle loro spalle e tu fai questo! Fammi scendere�
voglio scendere!�
�Cosa credi che abbia fatto� sto
semplicemente cercando posto per i nostri operai � loro escono e quelli
entrano��. Mario mi torna in mente: mi porta il proprio dolore inscritto in una
categoria: l�altro che � la tua speranza e che ti abbandona. Ci� che conta non �
che l�altro sia buono e ti aiuti - questa forse � un�antica forma di violenza
innocente (Bollas) � ma solo che l�altro possa incuriosirsi per la tua giusta
rabbia, per gli abiti di lino incredibilmente bianchi e puliti e per i tuoi
occhi lucidi. Bont� � piet� sono spesso forme raffinate di violenza, anzi, di
falsit�. Solidariet� e commozione ci riguardano profondamente, l�altro ne � solo
l�occasione. �Per la strada, non so perch�, mi sentii invaso dalla bizzarra
sensazione di essere un impostore� (Conrad, 1899, 18).
Giuseppe Riefolo

|